Acqua e Carbonio
per il nostro futuro 1/2
Il suolo (… [1] [2]
) biologicamente attivo è in grado di trattenere grandi
quantità di acqua (… [1] [2] [3]
[4] [5] [6] ) e di carbonio
(… [1]
[2]
[3]
).
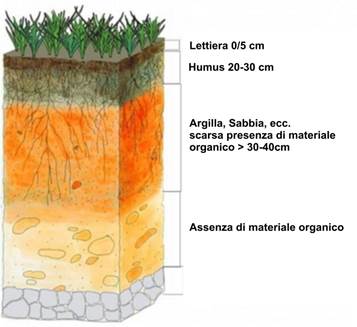 La vita degli organismi terrestri e
dell’uomo dipende dallo stato di salute di poche decine di centimetri di
terreno.
La vita degli organismi terrestri e
dell’uomo dipende dallo stato di salute di poche decine di centimetri di
terreno.
E’ da più di
6000 anni che l’uomo ha iniziato ad arare il terreno, molti terreni venivano
arati per seminare i cereali, molte zone, oggi aride, sono la conseguenza di
quelle arature.
In un documento della FAO del 2021, si
evidenzia che oltre l’80% delle terre agricole presentano condizioni di degrado
dovute alla
perdita della qualità del suolo, seguita dalla perdita di biodiversità e
dall'esaurimento delle risorse idriche.
Le cause del degrado sono dovute a pratiche agricole che facilitano l'erosione del suolo da parte di acqua e vento, la perdita di materiale organico, la compattazione del terreno in superficie, la salinizzazione e l'inquinamento del suolo e la perdita dei nutrienti.
L’aratura,
eliminando la copertura vegetale espone il terreno, per periodi più o meno
lunghi, all’azione diretta del sole, dell’acqua e del vento. L’assenza della
copertura vegetale ha come conseguenza la diretta esposizione a:
 sole: aumenta
la differenza di temperatura giorno-notte con rapido disseccamento della parte
superficiale.
sole: aumenta
la differenza di temperatura giorno-notte con rapido disseccamento della parte
superficiale.
 acqua: si
riduce la capacità di assorbimento e di resistere al dilavamento
acqua: si
riduce la capacità di assorbimento e di resistere al dilavamento
 vento: il
disseccamento e la frantumazione della parte superficiale originano particelle
che vengono facilmente sollevate e allontanate dal vento
vento: il
disseccamento e la frantumazione della parte superficiale originano particelle
che vengono facilmente sollevate e allontanate dal vento
Se poi a
questo aggiungiamo l’uso di sostanze chimiche (concimi, e pesticidi) che agiscono negativamente sui microrganismi
del terreno si completano le azioni che riducono la fertilità. Con la perdita
degli strati superficiali diminuisce la materia organica e con essa anche la
capacità di trattenere acqua, al tempo stesso si ha l’inversione del ciclo del
carbonio, anziché essere accumulato viene rilascio in atmosfera.
 L’incapacità del terreno di resistere
agli agenti atmosferici innescano processi di erosione
(… [1]
[2] [3] immagini ), tutto ciò favorisce la lenta ma, spesso, inarrestabile desertificazione.
L’incapacità del terreno di resistere
agli agenti atmosferici innescano processi di erosione
(… [1]
[2] [3] immagini ), tutto ciò favorisce la lenta ma, spesso, inarrestabile desertificazione.
Si dà per scontato
che la causa dell’inaridimento del
suolo sia la mancanza di acqua, di fatto le cause più rilevanti
sono costituite da alcune attività produttive dell’uomo: come le
coltivazioni intensive che depauperano il suolo, il pascolo
eccessivo che fa sparire la vegetazione e compatta la
terra, la
scorretta gestione delle risorse idriche,
l’eccessivo abbattimento di
alberi che trattengono lo strato più superficiale dei
terreni, e queste sono solo alcune delle cause che portano al degrado del
territorio.
 Dust Bowl – negli Stati Uniti è ricordato come
un periodo catastrofico, fra il 1931 e il 1938, le gradi pianure che si
estendono, nella parte centrale che va dal Canada fino ai confini col Messico
furono devastate da numerose tempeste di sabbia. Erano la patria dei bisonti
sterminati sul finire del secolo precedente, arrivati gli agricoltori
iniziarono ad ararle distruggendo l’erba che da sempre ricopriva questi
territori. Terre soggette a periodi siccitosi, il suolo scoperto si seccò
sgretolandosi, tempeste di vento sollevarono immense nubi di sabbia che
seppellirono case e interi paesi, gran parte della terra rimossa dal vento finì
nell’oceano Atlantico (… img
).
Dust Bowl – negli Stati Uniti è ricordato come
un periodo catastrofico, fra il 1931 e il 1938, le gradi pianure che si
estendono, nella parte centrale che va dal Canada fino ai confini col Messico
furono devastate da numerose tempeste di sabbia. Erano la patria dei bisonti
sterminati sul finire del secolo precedente, arrivati gli agricoltori
iniziarono ad ararle distruggendo l’erba che da sempre ricopriva questi
territori. Terre soggette a periodi siccitosi, il suolo scoperto si seccò
sgretolandosi, tempeste di vento sollevarono immense nubi di sabbia che
seppellirono case e interi paesi, gran parte della terra rimossa dal vento finì
nell’oceano Atlantico (… img
).

Le Grandi
Pianure coprono una superficie superiore ai 2.5 milioni di kmq, sul finire del
1934, circa 800.000 kmq erano da considerarsi a livello di deserto. In quegli
anni Franklin
Delano Roosevelt fondò il Soil Conservation
Service (oggi Natural Resources
Conservation Service) con il
compito di favorire le tecniche colturali che potessero recuperare e conservare
il suolo.
 L’aratura è il punto
di partenza del degrado del suolo, l’eliminazione della copertura verde e
l’esposizione agli agenti atmosferici favoriscono la diminuzione della materia
organica e con essa si hanno modifiche dei cicli dell’acqua e del carbonio (… [1] [2]
[3] [4]
),
fondamentali per mantenere un suolo
L’aratura è il punto
di partenza del degrado del suolo, l’eliminazione della copertura verde e
l’esposizione agli agenti atmosferici favoriscono la diminuzione della materia
organica e con essa si hanno modifiche dei cicli dell’acqua e del carbonio (… [1] [2]
[3] [4]
),
fondamentali per mantenere un suolo 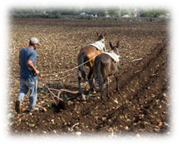 sano.
sano.

Le
piante (alberi, arbusti, erbe) o meglio la foglia è il punto d’ingresso del
carbonio verso il terreno. Con la fotosintesi
clorofilliana (… [1] [2] ) le piante
trasformano la CO2 in carboidrati che
tramite la linfa vengono distribuiti al resto della pianta. La gran parte delle
piante ha rapporti simbiotici con i microrganismi del terreno, in particolare
con le micorrize dei funghi (… [1] [2]
[3] ). Il carbonio, attraverso le radici, sotto
forma di carboidrati viene scambiato con varie sostanze minerali metabolizzate
dai microrganismi e assorbite dalle radici.
Il
sistema suolo è un analogo del nostro microbiota intestinale formato da un numero di cellule almeno
10 volte superiore a quelle che compongono il nostro corpo; il microbiota trasforma il cibo che mangiamo in sostanze
nutritive assorbite dal nostro organismo. Qualunque sostanza che interferisce
negativamente con il metabolismo del nostro microbiota
finisce per compromettere la nostra salute.
La
cooperazione fra piante e microrganismi del suolo permette di fissare enormi
quantità di carbonio estraendolo dall’aria; Il suolo è un ambiente vivo, ma
arature, monocolture, riduzione della copertura vegetale, sostanze chimiche
come pesticidi e concimi ne riducono la vitalità finendo per contrastare il
processo di fissazione del carbonio. Venendo meno lo scambio fra piante e
microrganismi diminuisce la massa organica presente nel terreno, si riduce la
capacità di trattenere acqua, si velocizza il flusso del carbonio che dal suolo
ritorna in atmosfera portando in negativo il bilancio fra quello accumulato e
quello rilasciato. Il terreno diventa più soggetto all’erosione, in quanto la
perdita di sostanza organica, la mancanza di copertura vegetale ne facilita lo
sgretolamento rendendolo particolarmente soggetto al dilavamento e all’azione
del vento.
 Nei terreni
coltivati con utilizzo dei prodotti chimici quali pesticidi e concimi la
presenza di microrganismi è molto bassa a causa della tossicità delle sostanze
utilizzate. Il sistema pianta-
Nei terreni
coltivati con utilizzo dei prodotti chimici quali pesticidi e concimi la
presenza di microrganismi è molto bassa a causa della tossicità delle sostanze
utilizzate. Il sistema pianta- radici-microrganismi-fissazione
del carbonio è compromesso, il carbonio non si accumula, e quello presente
tende a ritornare in atmosfera.
radici-microrganismi-fissazione
del carbonio è compromesso, il carbonio non si accumula, e quello presente
tende a ritornare in atmosfera.
Le
origini dell’agricoltura industriale le possiamo far risalire allo scienziato
tedesco Fritz Haber che nel 1911 mise a punto il
processo per la produzione di ammoniaca a partire da idrogeno e azoto. Nacquero
i primi fertilizzanti sintetici grazie ai quali si ebbe un notevole  aumento della produzione agricola, ma accanto
ad essi Haber mise a punto
aumento della produzione agricola, ma accanto
ad essi Haber mise a punto 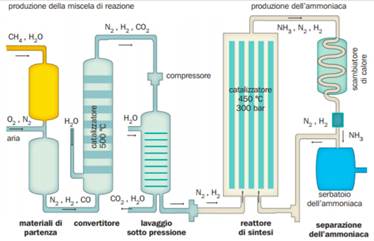 anche i primi
pesticidi che inizialmente vennero utilizzati nella Ia
guerra mondiale come armi chimiche.
anche i primi
pesticidi che inizialmente vennero utilizzati nella Ia
guerra mondiale come armi chimiche.
Gli
sviluppi tecnologici per combattere in guerra si riversarono sull’agricoltura che
si trasformò velocemente; l’arrivo di fertilizzanti prima e poi dei pesticidi
permise a molti agricoltori di aumentare in tempi brevi le rese dei raccolti.
Bastava spargere queste sostanze sui terreni e non era più necessario
preoccuparsi della loro gestione.
L’agricoltura
diventò una catena di montaggio: monocolture e allevamenti intensivi divennero
rapidamente la normalità, l’agricoltore si trasformò in un tecnico
specializzato in una particolare attività. Sapeva tutto su come aumentare la
produzione del grano o del bestiame ma ben poco su come conservare la fertilità
del 
 suolo a questo
ci pensavano i concimi ed i pesticidi
che si occupavano di eliminare la concorrenze delle erbacce e degli insetti.
suolo a questo
ci pensavano i concimi ed i pesticidi
che si occupavano di eliminare la concorrenze delle erbacce e degli insetti.
L’agricoltore
abbandonò il terreno per salire sulle macchine e diventare un esperto di
chimica, la graduale perdita di fertilità dei terreni veniva compensata
dall’aumento dei  fertilizzanti:
nel 2020 sono necessari una quantità di
fertilizzanti:
nel 2020 sono necessari una quantità di  fertilizzanti 3
volte maggiore che nel 1960 per ottenere
la stessa quantità di grano. La chimica ha mascherato la perdita di
fertilità dei terreni
fertilizzanti 3
volte maggiore che nel 1960 per ottenere
la stessa quantità di grano. La chimica ha mascherato la perdita di
fertilità dei terreni
 L’agricoltura
moderna è dissociata dal terreno, le coltivazioni sono geneticamente sviluppate
per resistere ai pesticidi e sfruttare al meglio i fertilizzanti utilizzati.
Negli USA, la coltura principale è il
L’agricoltura
moderna è dissociata dal terreno, le coltivazioni sono geneticamente sviluppate
per resistere ai pesticidi e sfruttare al meglio i fertilizzanti utilizzati.
Negli USA, la coltura principale è il  mais da
foraggio che è quasi ovunque trattato con glifosato (… [1] [2] ). E’ un potente erbicida
che si è diffuso un po’ ovunque dall’acqua potabile al latte materno; ogni anno
1,4 kg di pesticidi per ogni americano sono distribuiti nei terreni e sugli
alimenti (1,9kg in Italia). Centinaia di studi
collegano l’uso di queste sostanze a patologie che colpiscono i bambini come ADHD (disturbo dell’attenzione, iperattività), tumori e
mais da
foraggio che è quasi ovunque trattato con glifosato (… [1] [2] ). E’ un potente erbicida
che si è diffuso un po’ ovunque dall’acqua potabile al latte materno; ogni anno
1,4 kg di pesticidi per ogni americano sono distribuiti nei terreni e sugli
alimenti (1,9kg in Italia). Centinaia di studi
collegano l’uso di queste sostanze a patologie che colpiscono i bambini come ADHD (disturbo dell’attenzione, iperattività), tumori e  malformazioni.
Sempre più spesso vengono riconosciuti nei tribunali i legami fra queste
sostanze e malattie come il disturbi e malattie che possono portare al cancro. Queste sostanze come uccidono
i microrganismi, passando nel nostro cibo, continuano il loro effetto anche sui
microrganismi presenti nel nostro intestino.
malformazioni.
Sempre più spesso vengono riconosciuti nei tribunali i legami fra queste
sostanze e malattie come il disturbi e malattie che possono portare al cancro. Queste sostanze come uccidono
i microrganismi, passando nel nostro cibo, continuano il loro effetto anche sui
microrganismi presenti nel nostro intestino.
L’agricoltura
industriale, dagli USA, si è gradualmente diffusa nel resto del mondo, si
calcola che dal 1970 ad oggi si è persa almeno 1/3 della copertura vegetale dei
terreni. La diminuzione della fertilità dovuta alla perdita di sostanza
organica ha come conseguenza il rilascio di grandi quantità di carbonio
nell’atmosfera. La perdita di copertura vegetale aumenta la temperatura del
terreno che a sua volta velocizza il processo di rilascio della CO2.
Un
suolo sano opera assorbendo acqua e C02,
quando l’agricoltura si trasforma in industria dove monocolture abbinate a
continui trattamenti chimici riducono la copertura vegetale, il terreno perde
la capacità di trattenere acqua e CO2, si
sgretola e diventa polvere dando inizio al processo di desertificazione.
L’inaridimento è completato dalla pioggia e dal vento che 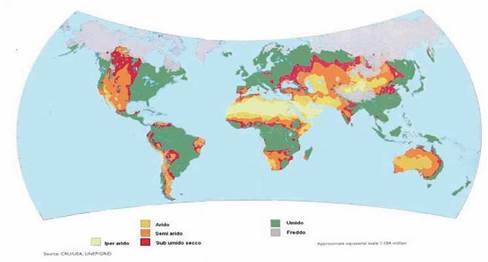 agiscono
erodendo e disperdendo la parte viva del terreno.
agiscono
erodendo e disperdendo la parte viva del terreno.
Suolo,
piante e clima sono collegate, senza piante vive, la temperatura del terreno
aumenta rapidamente, si ha una maggiore evaporazione che determina una rapida
perdita di umidità del terreno, l’aria più calda e con minor umidità relativa
si disperde avviando i processi di desertificazione. Al contrario la traspirazione delle piante
(quando l’umidità esce attraverso le piante), oltre a conservare un terreno più
umido mitiga la temperatura aumentando l’umidità relativa dell’aria, ciò crea
un microclima che favorisce la formazione di piogge.
La
misura di quanto detto è ben evidente se confrontiamo l’escursione termica in
un terreno nudo e un analogo terreno coperto di vegetazione, questa può
raggiungere valori doppi rispetto a quello coperto. Se aumenta la superficie a
terreno nudo si finisce per modificare il microclima, ma se ciò avviene a
livello mondiale di modifica quello del pianeta. I processi di desertificazione
stanno interessando i due terzi dei terreni agricoli a livello mondiale.
La
storia è piena di civiltà scomparse in
conseguenza dell’aumento della popolazione e della degradazione dell’ambiente,
oggi accade a livello mondiale, fame, immigrazione, disordini sociali, guerre
sono la logica conseguenza di questo degrado ambientale.
Il
nostro modo di nutrirci è alla base di questi fenomeni di degrado e se
continuiamo su questa strada la diagnosi non può che essere molto negativa. Le
Nazioni Unite, a questi ritmi, indicano che il terreno agricolo scomparirà in circa
60 anni.
Attraverso
lo sfruttamento del terreno, l’agricoltura è da millenni che ha dato il via
alla liberazione di CO2 nell’atmosfera,
processo che ha portato all’aumento della popolazione 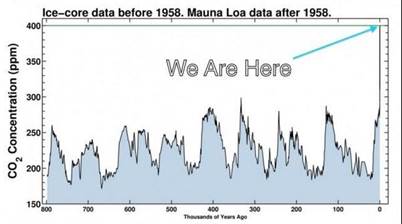 che a sua volta
ha amplificato i processi di sfruttamento del nostro pianeta. Oggi ci troviamo
con livelli elevatissimi di CO2 che, con alta probabilità,
determineranno rapidi cambiamenti climatici, una possibile soluzione è quella
di invertire il processo riportando la CO2
nel suolo.
che a sua volta
ha amplificato i processi di sfruttamento del nostro pianeta. Oggi ci troviamo
con livelli elevatissimi di CO2 che, con alta probabilità,
determineranno rapidi cambiamenti climatici, una possibile soluzione è quella
di invertire il processo riportando la CO2
nel suolo.
Questa
strada passa forzatamente utilizzando ciò che noi continuiamo a distruggere:
piante, arbusti, erbe e riportare gli animali al pascolo in maniera
intelligente per catturare la CO2 e
depositarla nel suolo. E’ un processo fattibile, non immediato ma fattibile, è
una tecnologia che esiste da milioni di anni che cattura anidride carbonica
dall’atmosfera e la deposita nel terreno ed è l’interazione fra piante e
microrganismi presenti nel suolo. Per realizzare questo semplice processo serve
la politica, proprio quella che a tutt’oggi ha semplicemente favorito l’aumento
della CO2.
 Nel 2015, a
Parigi c’è stato il vertice delle Nazioni Unite sul clima (Cop21Paris),
vi hanno partecipato 196 paesi per discutere su come affrontare il problema del
cambiamento climatico. Fra i tanti discorsi, promesse e tante parole c’è stata
una sola proposta concreta in grado di affrontare veramente la questione
dell’aumento delle
Nel 2015, a
Parigi c’è stato il vertice delle Nazioni Unite sul clima (Cop21Paris),
vi hanno partecipato 196 paesi per discutere su come affrontare il problema del
cambiamento climatico. Fra i tanti discorsi, promesse e tante parole c’è stata
una sola proposta concreta in grado di affrontare veramente la questione
dell’aumento delle  temperature, la
proposta è stata fatta dall’allora ministro dell’agricoltura francese Stéphane Le Foll, tale proposta
si basa su un progetto detto “iniziativa
4 per 1000” che ha per obbiettivo l’aumento del carbonio nel suolo.
temperature, la
proposta è stata fatta dall’allora ministro dell’agricoltura francese Stéphane Le Foll, tale proposta
si basa su un progetto detto “iniziativa
4 per 1000” che ha per obbiettivo l’aumento del carbonio nel suolo.
 Se si riesce, a livello mondiale, ad aumentare il
contenuto di carbonio del suolo dello 0,4% all’anno si catturerebbe
l’equivalente di CO2 emesse
dall’uomo nello stesso anno. Il suolo è in grado di incamerare enormi quantità
di carbonio, quasi 3 volte quello contenuto dall’atmosfera e dalle piante.
Se si riesce, a livello mondiale, ad aumentare il
contenuto di carbonio del suolo dello 0,4% all’anno si catturerebbe
l’equivalente di CO2 emesse
dall’uomo nello stesso anno. Il suolo è in grado di incamerare enormi quantità
di carbonio, quasi 3 volte quello contenuto dall’atmosfera e dalle piante.
 30 paesi hanno
aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di agire sulle attività agricole in
modo da indirizzarle verso tecniche colturali in grado di catturare carbonio
dall’atmosfera.
30 paesi hanno
aderito all’iniziativa, con l’obiettivo di agire sulle attività agricole in
modo da indirizzarle verso tecniche colturali in grado di catturare carbonio
dall’atmosfera.

E’
un’agricoltura a basso utilizzo di sostanze chimiche e di OGM che però non ha
trovato la disponibilità di USA, India e Cina.
Anche
se azzerassimo tutte le fonti di gas serra, in primis le fonti fossili, e
passiamo all’utilizzo delle sole fonti rinnovabili ciò non cambierebbe niente
per quanto riguarda la CO2 già immessa
nell’atmosfera. Dall’inizio della rivoluzione industriale (1750) ad oggi
abbiamo immesso CO2 per oltre 1000
miliardi di tonnellate più che sufficienti per l’evolversi dei cambiamenti
climatici per i prossimi decenni. Parlare solo di ridurre le emissioni avrà ben
poco effetto sulla dinamica già avviata se non si affronta il reale problema:
la riduzione di CO2 presente
nell’atmosfera! Lo possiamo fare, ma dobbiamo rifondare la nostra agricoltura,
diffondere le tecniche che migliorano il suolo significa ridurre i fabbisogni
di acqua e aumentare la sostanza organica del terreno favorendo i processi di
cattura del carbonio. Ridurre la CO2 è
possibile e solo così possiamo dare una speranza per il futuro del nostro
clima.
Acqua e carbonio per il nostro futuro
Claudio Cerioni
ott. 2021
la fonte principale è il documentario
“Kiss the ground”